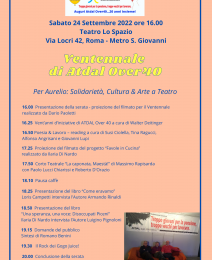#stateacasa
Luna de Magistris
«Dobbiamo prepararci, esserne sicuri» dice Tommaso, porgendomi la mascherina.
«Non so se voglio farlo» rispondo io, afferrandola con le mani.
«Non abbiamo altra scelta» ribatte.
Mi guarda, serio, con la fronte corrugata e gli angoli della bocca che pendono verso il basso, vittime della forza di gravità. Faccio un respiro profondo e annuisco, perché so che ha ragione: non possiamo restare chiusi qui in eterno. Anche se è difficile abbandonare il luogo in cui, per mesi, siamo stati rinchiusi. Un luogo che potrei perfino chiamare “casa”, perchè, in fondo, per tutto questo tempo lo è stata. La nostra casa. Mura di cemento armato ricoperte da piastrelle luride come quelle di un bagno pubblico di periferia. Le mura che ci hanno tenuti al sicuro dall’epidemia.
Ricordo perfettamente il giorno in cui il Presidente annunciò l’inizio della quarantena. Ero seduta sul divano e la luce del tramonto filtrava violenta attraverso le tende del salotto, il profumo di cioccolata dalla cucina e le mani di Tommaso che posavano la tazza sul tavolo basso di fronte a me.
All’inizio, erano in pochi a fare caso agli sviluppi del contagio, non c’era ancora stato il boom mediatico, non era ancora diventato uno scoop. Alla TV si parlava di un contagio circoscritto ai territori adiacenti al focolaio e nient’altro. Ma non c’era voluto molto prima che il virus si diffondesse altrove. Asia, Africa, Europa e poi America. E nel giro di qualche giorno i voli erano bloccati e gli ospedali in sovraffollamento. In un certo senso fu tutto improvviso: la chiusura delle scuole, degli alberghi e dei ristoranti, lo smart working, il conteggio dei morti, le cremazioni di gruppo. E poi la corsa ai supermercati, ai negozi di armi, alle farmacie. Il chiudersi in casa e dare la doppia mandata alla porta, continuando compulsivamente a leggere post e notizie, guardare video diffusi dai contagiati, preoccuparsi costantemente per i parenti lontani, aver paura di contagiarsi e morire, aver paura di contagiare e uccidere, sentirsi impotenti e in colpa, non vedere vie d’uscita… piangere. Piangere ogni giorno e non poter fare altro che rinchiuderti.
Improvviso, certo. Perché quando sei assorto in altro, il virus uscito dal laboratorio dall’altra parte del mondo è l’ultimo dei tuoi problemi. Ed è anche giusto: perché rinunciare alla tua vita se la cosa, per ora, non ti riguarda, né mai potrebbe farlo? Si può capire, si può comprendere, si può ritenere giusto. Ma non lo è continuare a pensarlo anche quando le persone accanto a te stanno morendo. Come si fa a fregarsene della comunità in questo modo? Perché non tutti hanno la stessa percezione del rischio? Che fine hanno fatto il senso civico e la responsabilità sociale?
All’epoca dell’annuncio, i morti avevano superato i guariti dell’ottanta percento. All’epoca dell’annuncio, tutte le misure protettive e restrittive attuate fino ad allora non avevano funzionato. Le persone continuavano ad aggregarsi, cercavano scuse per uscire, trovavano cavilli nei decreti per essere giustificati a farsi la corsetta mattutina e a portare il cane a pisciare tra le quindici e le diciotto volte al giorno sebbene non fosse incontinente. All’epoca dell’annuncio, Tommaso ed io eravamo chiusi in casa da giorni e forse eravamo tra i pochi a seguire alla lettera le regole e le prescrizioni dei decreti. E il pensiero che questo non bastasse, ci stava uccidendo. Peggio dell’epidemia. Peggio di apprendere da uno sconosciuto che la tua famiglia è stata contagiata e che non gli aspetta altro che la morte. E un triste funerale inesistente.
«Sono sicuro che il nostro paese si riprenderà» diceva il Presidente alla TV ormai sempre in sottofondo, parole soffocate dal megafono gracchiante della volante dei vigili all’esterno che ripeteva incessantemente di stare a casa. Stare a casa, come se il significato fosse davvero questo. Ma non lo era. Stare a casa significava “stare attenti”. Perché gli ospedali erano saturi e se stavi male, dovevi vedertela da solo. «Sono sicuro che l’Italia si rialzerà in piedi» diceva ancora il Presidente, dopo un colpo di tosse.
Tommaso, seduto al mio fianco, prese in mano il telecomando, stanco di sentire quella voce roca che ormai ci faceva compagnia costantemente, e fece per cambiare canale. Ma il suo dito si bloccò a mezz’aria, quando la voce disse «Ma». Ma… era come il “ma” detto da una ragazza per friendzonarti: sei carino, ma ti vedo solo come un amico. Siamo stati bene stanotte, ma per me eri solo un diversivo. L’Italia si riprenderà «ma dovremo prendere misure drastiche». E quando al suo fianco apparve il volto disciplinato del Generale Meyer, avevamo capito. Non c’era bisogno di chiedere a cosa si riferisse con quel “misure drastiche”. Significava che le nostre vite erano appese a un filo e la nostra libertà era fottuta. Completamente.
Anche se entrambi guardavamo in silenzio il televisore, nessuno dei due stava davvero ascoltando. Sentivamo i nostri cuori spezzarsi e le lacrime rigarci le guance in silenzio, consapevoli che l’illusione era finita. Non potevamo più sperare in un miracolo, non potevamo più lasciare il nostro destino nelle loro mani, nelle mani di quelli che decidono. Ora stava a noi fare una scelta.
Ne parlavamo da diversi giorni, forse da quando eravamo di fatto diventati entrambi orfani. O forse da quando il bollettino medico aveva smesso di elencare i nomi dei deceduti.
Volevamo rinchiuderci per davvero. Dire addio alla nostra vita e scendere in cantina. Barricare la porta e aspettare. Volevamo smetterla di preoccuparci degli altri, perché gli altri non lo facevano per noi. Volevamo essere egoisti, perché tanto ormai l’egoismo si era trasformato in lotta per la sopravvivenza.
Tommaso si girò verso di me e, senza dire nulla, mi prese la mano. Sospirai e smisi di piangere. Insieme ci alzammo dal divano e iniziammo a fare le valigie. In silenzio, per tutto il tempo che servì a prendere tutto ciò che riuscimmo a prendere e a trascinare per le scale ripide che portavano alla cantina attrezzata a bunker antiatomico. Tutto, tranne i telefoni e la TV. Perché isolarsi per davvero, significava isolarsi in ogni senso. Tanto, di persone da chiamare ne erano rimaste poche.
Il tempo scorreva e alla porta barricata non si presentò mai nessuno. Nè mai fummo tentati dagli squilli del telefono. Il tempo scorreva e l’umidità che ti entrava nelle ossa diventava un’abitudine. E dopo un po’ anche il dubbio di vivere un incubo, diventava abituale. Non spariva, ma non ci facevi più caso, semplicemente. Il ticchettìo dell’orologio scandiva i momenti di infinite giornate silenziose trascorse a fare ginnastica e a cucinare fagioli col fornello elettrico. L’elettricità, per fortuna nessuno era venuto a staccarcela, nonostante le bollette non pagate. Neanche l’acqua ci hanno staccato. Perciò le giornate erano intense, quasi normali. Litigavi, scopavi e mangiavi.
Ma le notti. Le notti erano tremende.
Ti svegliavi in preda al panico, dopo l’ennesimo incubo in cui vedevi la gente morire. Il senso d’angoscia ti opprimeva il petto e volevi solo alzarti e urlare. E qualche volta lo facevi, tanto non ti sentiva nessuno. E tu non sentivi nessuno, eri completamente solo. Come non lo eri mai stato.
Ti chiedevi se tutto questo sarebbe finito, prima o poi. Se allontanarti dal resto del mondo era stata una buona idea. Ti chiedevi se un giorno l’avresti rivisto, quel mondo. Ma sapevi, dentro di te, che non sarebbe più stato lo stesso. Sarebbe cambiato, tutto. Le persone sarebbero cambiate, le vite di tutti sarebbero state diverse, nuove. Terribili. Ti chiedevi se ne valeva la pena, di vivere. Di continuare a sperare, di continuare a far vivere dentro di te quel piccolo bagliore di speranza, flebile come la luce di una candela consumata.
Avremmo mai avuto una famiglia, dei figli? Saremmo mai stati in grado di costruirci una nuova esistenza, dopo tutto questo? Potevamo continuare a chiedercelo all’infinito, ma non avremmo mai avuto una risposta. Non restando qua dentro. Soli con i nostri pensieri e le nostre paure. Col cibo che scarseggia e senza contatto umano, al di fuori del nostro.
«Promettimi che ce la faremo» dico, tremando e cercando il suo sguardo. Tommaso mi stringe la mano guantata, ancora una volta. E la sua stretta dice più di ogni superflua parola.
Indosso la mascherina, mentre lui apre la porta della cantina e l’odore di disinfettante mi riempie i polmoni. Saliamo lenti le scale ripide che portano al soggiorno e la luce abbagliante del sole pomeridiano mi acceca, costringendomi a chiudere gli occhi. Il soggiorno è così come lo avevamo lasciato, mesi fa. Tutto è al suo posto, come se ci stesse aspettando, immobile e ricoperto di polvere. Vorrei poter dire che il tempo si è fermato, vorrei guardare il calendario e tornare a quel giorno in cui abbiamo preso la decisione più dura della nostra vita. Ma non si può. Il tempo va avanti, anche senza di te. E anche il mondo. Lo stesso mondo ferito e deserto che ci attende fuori dalla finestra. I rottami incendiati, i cadaveri accatastati sul marciapiede, gli animali che circolano indisturbati sfuggendo alla minaccia umana. Il cielo ricoperto da nuvole scure. E il silenzio. Il silenzio cupo di una terra ormai vuota. Una terra che abbiamo portato allo stremo e che ci ha sterminati. Tutti, nessuno escluso. Anche se noi siamo qui, gli ultimi due superstiti. Quelli che avranno il compito più arduo di tutti: sperare, ancora, e vivere.