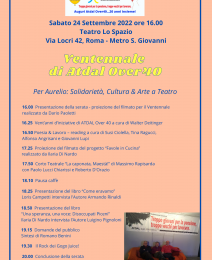Social specchio dell’anima o della società?
Mala tempora currunt. Sic transit gloria mundi.
Un tempo, lo specchio dell’anima erano gli occhi, da scrutare, da fissare o da evitare, in un gioco di inseguimenti di sguardi tenero, pudico e magari un po’ puerile.
Gli occhi dell’amata in cui perdersi, gli occhi di una innamorata, da evitare come fosse lo sguardo di una regina crudele, o di un sole dal quale ci saremmo fatti piacevolmente accecare e incenerire. Perché bruciare significava essere visti, essere amati, amare. Gli occhi di un amico in cui confidare o di un nemico da sfidare. Gli sguardi ci tradivano a volte, ma faceva parte del gioco, un gioco in cui nessuno poteva nascondersi dietro facili maschere o trucchi da film di fantascienza. Sì, esisteva la menzogna, l’ipocrisia, esisteva la paura di lasciarsi andare o il “timore di mostrarsi interamente nudo”, come cantava Battisti (timore che ora appare totalmente svanito).
Ma si era veri, anche quando si mentiva. Nessun filtro, nessun foto ritocco.
È vero, gli haters erano quelli che ti parlavano alle spalle, anziché scrivere parolacce sulla bacheca, qualche ragazzo si sarà messo un calzettone appallottolato nei pantaloni e qualche ragazza avrà imbottito le tette, anziché photoshopparsi, ma alla fine eri quello che la gente vedeva.
Adesso, il paradosso della società del culto massimo dell’apparenza, è scomparire, dietro una tastiera, uno schermo, dietro parole ragionate e meditate per ore, giorni, in un falso contraddittorio o buttate lì, senza pensare, perché il tempo si è improvvisamente velocizzato, volatilizzato e devi twittare più svelto di un uccellino e instagrammare in un batter d’occhi, perché ieri è già un trapassato remoto (quanti giovani sanno cos’è un trapassato remoto? È un morto molto morto. Più morto di Zed e del congiuntivo).
E così esisti solo se scompari, se decidi volontariamente di rinunciare a esistere come persona in carne e ossa e accettare di (non) essere una serie di algoritmi inventati da chi fa molti soldi, grazie a te, grazie al tuo avatar. Non siamo più persone pensanti, non siamo λόγοι, ma loghi, spot di noi stessi, perlomeno di quella parte di noi di noi che cerchiamo di ve(n)dere.
Se anni fa qualcuno ci avesse detto che avremmo lavato in pubblico i nostri panni sporchi (anziché sciacquarli in Arno), accettando di rivelare a tutto il mondo i nostri spostamenti, i nostri pensieri, i nostri gatti, le nostre idee politiche, i nostri dati sensibili, le nostre foto osé, rinunciando definitivamente alla libertà di non avere una opinione su tutto, beh, avremmo dato del pazzo e del mitomane a quel qualcuno.
Invece, come sempre, la fantasia supera la realtà. E stavolta l’ha superata a tal punto, da cancellarla definitivamente.
Un tempo si poteva valutare qualcuno dalle amicizie che frequentava. Adesso siamo amici del Mondo intero e la qualità ha lasciato spazio alla quantità. A contare sono i followers, i like, i contatori delle affluenze sul nostro sito, i cuoricini che riusciamo a strappare mettendo a nudo solo il meglio di noi, perché il “conosci te stesso” di delfiana memoria si è trasfigurato nella misera (il)logica estetica del selfie. Io io io e ancora io. L’ego smisurato si è amplificato grazie all’eco di internet. Prima ti vantavi con gli amici. Adesso col mondo intero.
I social network sono il male? No, il male ce lo siamo fatti da soli e ce lo facciamo ogni volta che ci inchiniamo sul cellulare. Quante persone incontriamo capaci ancora di alzare gli occhi al cielo, per fantasticare sulle nuvole (quelle vere, non il cloud)? Non lo possiamo sapere, perché siamo i primi che abbiamo passato il tempo a chattare e messaggiare e passiamo il tempo a whatsappare, telegrammare e snapchattare, anziché osservare il mondo intorno a noi. Il cielo potrebbe essere diventato verde e non lo sapremo mai. Perché il mondo, ora, è nelle nostre mani, o peggio, in quell’aggeggio che teniamo tra le mani, sì, proprio quello inventato per aiutarci a comunicare (resettate quel sorrisetto inopportuno dal viso, per favore. È un dramma che si sta consumando e, ahinoi, non ne è Shakespeare l’autore).
Anche i miliardi di fotografie che scattiamo, stanno sostituendo la nostra memoria (a che serve ormai, dato che c’è google?) e basta un virus, un bug, per cancellare infiniti ricordi, che pare quasi abbiamo vissuto solo per poterli scattare e scartare, quando siamo sicuri di volerli eliminare. Basta una domanda ripetuta due volte. Siete sicuri?
Cancel.
Siamo la generazione della dematerializzazione. Tutto quello che ci serve è nella memoria di un iPad.
Claude Sautet faceva dire a monsieur Arnaud che i computer erano strani: “così tanta memoria, ma nessun ricordo“. Ora i ricordi ce li mettiamo noi, nel computer. I nostri. Basterebbe una guerra tra hackers per cancellare non solo i ricordi individuali, ma anche la memoria collettiva. E probabilmente la società stessa per come l’abbiamo concepita.
Non sappiamo farci più una pizza con gli amici, ma siamo sempre più social. Non sappiamo chi abita alla porta accanto (perché se finisce il pane, possiamo comprarlo dal pakistano sotto casa aperto h24), ma ci illudiamo di essere amici del nostro idolo sportivo o dell’attrice hollywoodiana del momento.
E allora? I social sono l’orribile strumento nelle mani di un Grande Fratello che neanche Orwell, nei suoi peggiori incubi lovecraftiani, avrebbe potuto immaginare?
No, sono soltanto lo specchio dell’anima, un’anima che abbiamo inaridito, poco a poco, come un deserto che, granello dopo granello, corrode ogni cosa. La nostra anima è povera, misera, fragile e allora il social network non è altro che il profumo che i nobili francesi spruzzavano sulle croste puzzolenti della loro sporcizia, il tappeto sotto il quale la colf pigra nasconde la polvere della nostra esistenza, la luce accecante che una vecchia soubrette della Tv si fa sparare sul volto per nasconderne le rughe.
Il male, siamo sempre e soltanto noi il male e non c’è virgola cumana che possa alterare a nostro piacimento il senso della frase, per non farci morire “in bello“.
Il male sono i padri e le madri che non sanno dire di no ai figli, che si illudono di controllarli, chiedendo loro l’amicizia su Facebook; il male sono i pavidi insegnanti che accettano programmi scolastici aridi e stantii; il male sono i politici ignoranti che ci governano per generare altri ignoranti da controllare, perché la mela (marcia) non cade mai troppo lontana dall’albero (e di Newton, capace di cambiare il mondo con una mela, ne nasce uno ogni secolo); il male sono i figli di una televisione lobotomizzante, fatta di talents privi di talento, di isole di famosi sconosciuti, di battibecchi e ciarle insulse e insulti e inutili singulti, di veline svelate e pacchi vuoti, di lacrime finte e comici volgari e tristi, di applausi su richiesta e finte quinte.
Il male è dentro di noi. Ma abbiamo smesso di combatterlo, perché le etichette ci fanno paura e dare una definizione del male non è politically correct, né abbastanza radical chic. Le parole si impoveriscono di pari passo con la nostra (sub)cultura.
“Chi parla male pensa male e vive male“. E non è più in grado di parlare del male.
E adesso, tra miriadi di emoticon, non ci appare neanche più strano, se non siamo in grado di descrivere un’emozione a parole.
Diventeremo degli acronimi senza nemmeno accorgercene. L’involuzione è la nuova evoluzione. Non c’è più spazio per nessuna rivoluzione.
I social sono lo specchio di un’anima che riflette il nulla. Così ci illudiamo di combattere l’horror vacui, riempendo quel vuoto di mille sciocchezze, purché il silenzio cessi di gridarci contro.
“L’orrore ha un volto” che non vogliamo più riflettere nello specchio.
Ma un giorno, chissà, riusciremo a guardare nuovamente attraverso quello specchio.
E quel giorno, finalmente, scopriremo che il cellulare ha perfino un tasto di spegnimento e torneremo ad alzare gli occhi per riempirli del cielo più terso e luminoso che abbiamo mai visto. Poi, abbassando lo sguardo, ci accorgeremo che stiamo tenendo la mano di qualcuno nella nostra. E non ci fregherà più un cazzo di condividere quel momento con nessun altro…